
Anche se meno famosa delle sue colleghe, penso ad Artemisia Gentileschi, la pittrice Sofonisba Anguissola ha avuto una vita altrettanto affascinante.
Nata nel 1532, era la prima dei sette figli di Amilcare Anguissola e di Bianca Ponzoni, entrambi di famiglie nobili di Cremona, all’epoca della dominazione spagnola seconda città dello Stato di Milano per importanza e ricchezza, e grandi amanti dell’Arte e della cultura. In particolare, il padre Amilcare, disegnatore dilettante, per il suo tempo fu una personalità anticonformista: superando i pregiudizi dei contemporanei, egli non solo concesse alle figlie la possibilità di studiare letteratura, pittura e musica, secondo quanto suggerito dagli umanisti più illuminati, come Baldassarre Castiglione.
Quattro delle sorelle di Sofonisba, Elena, Lucia, Europa e Anna Maria divennero anch’esse pittrici. Elena, in seguito, abbandonò la carriera artistica per diventare una suora domenicana. La quinta sorella, Minerva, fu insegnante di latino e scrittrice, mentre l’unico fratello, Asdrubale, studiò latino e diventò musicista In più Amilcare, fece di tutto per promuovendone la notorietà delle figlie, tanto da rompere le scatole a quel misantropo di Michelangelo, spedendogli quantità industriali di lettere.
Tanto fece che Michelangelo, famigerato per il pessimo carattere, accettò, per toglierselo dalle scatole, di dare un’occhiata ai disegni delle figlie, preparandosi poi a rispondere con una delle sue famigerate battutacce… Vasari, infatti, dovrebbe essere fatto santo, per la sua pazienza e grande capacità di sopportazione..
I disegni arrivarono, tra cui uno di Sofonisba, che ritraeva il fratellino Asdrubale: Michelangelo rimase sorpreso, e invece di essere il solito criticone, disse che Sofonisba sapeva disegnare meglio di tanti suoi colleghi uomini.
Così, come racconta Tommaso Cavalieri, le lanciò una sfida: se tutti i pittori erano più o meno capaci di rappresentare un bambino sorridente, ben più complicato sarebbe stato dipingere uno che piangesse. Il tema avrebbe rappresentato il banco di prova delle capacità di Sofonisba, che accettò il compito.

Nacque così Il Fanciullo morso da un gambero, fonte di ispirazione per Il Fanciullo morso da un Ramarro di Caravaggio, che rappresenta sempre il fratellino Asdrubale, morso da un gambero nascosto in cestino, che piange a dirotto e viene consolato dalla sorellina Europa.
Michelangelo apprezzò molto il nuovo disegno e come premio, spedì a Sofonisba alcuni suoi disegni, affinché la ragazza potesse studiarli e colorarli. Subito dopo, Sofonisba fu messa a bottega presso il pittore manierista Bernardino Campi, il quale si rese conto come fosse, a differenza delle sorelle, poco portata per lo studio della matematica, della prospettiva e allergica alla polvere d’intonaco, che le rendeva complicato utilizzare la tecnica dell’affresco.
Per cui le consigliò di dedicarsi alla ritrattistica; fu un ottimo suggerimento. Con Sofonisba il ritratto non è solo l’immagine della persona, ma accenna alla sua storia; infatti, accompagna i volti straordinariamente somiglianti ed espressivi («tanto ben fatti che pare che spirino e siano vivissimi» scrisse il Vasari in persona dopo aver visto nel 1566 i ritratti di famiglia in casa Anguissola), con sguardi profondi, che suggeriscono gli infiniti mondi nascosti nell’animo umano, ed elementi, descritti con una minuzia fiamminga che, come tanti indizi, aiutano a ricomporre la personalità del soggetto raffigurato: un medaglione, un libro aperto, un guanto, un gioiello, uno spadino, secondo l’approccio tipico della ritrattistica cinquecentesca, ma con un naturalismo diretto che presuppone anche la conoscenza della pittura bresciana del Moretto e di quella bergamasca del Moroni. Lo stesso humus creativo da cui nascerà l’esperienza caravaggesca.
In ogni caso, il padre Amilcare, ottico press agent, Sofonisba riuscì in breve tempo a farsi conoscere nelle corti italiane ed europee – Annibal Caro in una lettera del 14 luglio 1556 scrisse «le cose sue son da principi» – a cominciare da quella spagnola dove arrivò nel 1559, per il tramite del duca d’Alba e del duca di Sessa, presso cui aveva soggiornato a Milano.
A Madrid, oltre a svolgere il compito di ritrattista reale, che le procurò una rendita annua di 200 scudi, fungeva da dama di compagnia e insegnante di pittura per la regina Elisabetta di Valois; alla sua morte, fu una sorta di tata tuttofare per le due infante di Spagna, Isabella e Caterina.
Nel frattempo però, il tempo passava e Sofonisba rischiava di rimanere zitella: per cui, Filippo II di Spagna, senza neppure interpellarla, decise di trovarle un marito, provando ad appiopparle qualcuno dei suoi nobili spagnoli. Sofonisba fece resistenza passiva, finché, stanca di dovere sopportare el Rey, che quando ci si metteva, era peggio di una pignatta di fagioli, accettò di sposarsi, a patto che il futuro marito fosse italiano.
Così Sofonisba fu sposata per procura nel 1573 a un altro famoso scapolone del tempo, Fabrizio Moncada, fratello del viceré di Sicilia; Filippo II, felice del suo ruolo di pronubo, fornì alla pittrice una ricca dote di 12000 scudi, numerosi gioielli e una pensione annua di 1000 ducati.
Sofonisba così si trasferì a Paterno, nel feudo del marito, che si fece in quattro per farla sentire a suo agio; cosa che provocò scandalo nella buona società siciliana dell’epoca, non solo permise a Sofonisba di continuare a dipingere, ma decise addirittura di diventare suo allievo.

La coppia dipinse assieme addirittura una pala d’altare, dedicata alla Madonna dell’Itria, l’ Odigitria, (dal greco bizantino Oδηγήτρια, colei che conduce, mostrando la direzione, composto di ὁδός «via» e ἄγω, ἡγέομαι «condurre, guidare») rappresentata secondo l’iconografia locale con la Vergine in una cassa portata da due anziani che apparentemente scelgono strade diverse. L’iconografia si rifà alla leggenda che narra di una contesa tra due paesi che volevano impossessarsi di un simulacro mariano, e che si sia conclusa con la costruzione del santuario là dove, al bivio, la Madonna divenne talmente pesante da non essere più trasportabile.
In più, nonostante la tradizione letteraria, Sofonisba fu in ottimi rapporti con il resto della famiglia Moncada: il tutto però cambiò nel 1578. La corte di Madrid tardava nel pagamento della pensione di Sofonisba e per difendere i diritti della moglie, Fabrizio si imbarcò per la Spagna, al seguito di don Carlo d’Aragona, principe di Castelvetrano e vicerè di Sicilia. Nei pressi di Capri, il convoglio fu però assalito da pirati algerini; seguì un duro combattimento, dove Fabrizio, distinguendosi per coraggio, riuscì a mettere in fuga i nemici.
Però la nave era così malridotta, che l’equipaggio e i passeggeri dovettero evacuarla a nuoto; in tale circostanza, però, Fabrizio morì affogato. Per qualche tempo, con l’aiuto del fratello Asdrubale, gestì il feudo di Paternò, poi stanca, decise di tornarsene a Cremona.
Così, viaggiando in nave diretta a Genova, a Livorno conobbe il nobile avventuriero e corsaro Orazio Lomellini; fu un colpo di fulmine e i due si sposaro a Pisa nel 1579. Cosa che provocò un enorme scandalo: Orazio era assai più giovane di Sofonisba e aveva una fama di scavezzacollo. Tutti, a cominciare da Filippo II, lo consideravano un cacciatore di dote.
In realtà, Orazio era profondamente innamorato di Sofonisba, tanto da trasformarsi per lei, progressivamente, in una persona tanto noiosa, quanto rispettabile. Per oltre trent’anni la pittrice visse con il marito a Genova continuando la sua opera di ritrattista per le famiglie aristocratiche della città e facendo registrare nei suoi dipinti le influenze del genovese Luca Cambiaso (Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino, Coral Gables, Florida, The Lowe Art Museum).
Ora piccola digressione storica: sin dai tempi dell’emirato kalbita, i rapporti commerciali tra Palermo e Genova erano assai stretti. Nel 1117, grazie a un trattato stipulato con Ruggero II, i Genovesi, già esperti conoscitori dell‟arte del mercanteggio, ottennero l‟esenzione dalle imposte ed il diritto ad avere un console, quale proprio rappresentante a Messina e nel 1300 ottennero il monopolio dell’esportazione del grano siciliano.
Cosa che portò alla nascita, a Palermo, di un loro quartiere nel cuore della città, tra il porto antico, detto la Cala ed il fiume Carraffo. Questo aveva uno schema molto semplice costituito da una piazza più un fondaco per il deposito delle merci, una chiesa, case e botteghe attigue. La struttura attorno alla quale ruotava l‟intera attività commerciale, era la loggia, una sorta di porticato che ospitava, al di fuori dei palazzi, i mercanti intenti agli affari: il termine loggia infatti trae origine dalla parola araba taq, arco.
Al piano terra delle logge si trattavano gli affari, si procedeva alle vendite di cui si prendeva nota in certi libretti detti ricordanze: qui avevano sede i consolati del mare ed altri enti collegati alle attività portuali mentre al piano superiore vi erano gli uffici dei notai, le banche e i tribunali. Le logge avevano una funzione di aggregazione, erano dotate in basso di alte finestre chiuse da cancelli di ferro che si elevavano su di un alto basamento che serviva da sedile per i mercanti.

Ovviamente, questa comunità aveva bisogno di una chiesa di riferimento: inizialmente fu data loro una cappella nei pressi della chiesa di San Francesco, la Capela Mercatorum Genuensium, decorata nel 1526 da un grandioso altare marmoreo di Antonello Gagini, che rappresenta San Giorgio e il Drago.
Nel 1437, precisamente un privilegio emanato da Alfonso re di Aragona e di Sicilia tolse la loggia ai Genovesi per concederla ai Catalani: i Liguri si sistemarono in un‟altra parte della stessa Piazza della Loggia, allo scoperto, perché ritennero che abbandonare del tutto quella zona della città sarebbe stato controproducente per i loro affari. Questa piazza rimase il fulcro delle attività commerciali dei Genovesi anche quando più tardi la stessa divenne Piazza Garraffello e fu abbellita, nel 1591, da una fontana opera di Vincenzo Gagini.

A partire dal 1564 i mercatores genovesi con il prospettarsi della nascita del nuovo porto, cominciarono ad avvertire la necessità di avvicinare la loro comunità alla nuova collocazione portuale. L’occasione propizia giunse esattamente nel 1576, quando la confraternita di San Luca in Palermo entrò in crisi non potendo far fronte alle spese di restauro della propria chiesa, situata vicino alla Porta di SanGiorgio.
I Genovesi seppero cogliere questa ottima opportunità stipulando con tale confraternita un accordo: il 9 Luglio 1576 acquisirono la proprietà di questa chiesa e dei terreni adiacenti con l‟impegno di ricostruirla a loro spese facendone un tempio dedicato al loro patrono, San Giorgio, con annesso ospedale per la cura della comunità ligure in Sicilia. Ai confratelli rimase il diritto ad una cappella per la sepoltura dei propri morti con l‟impegno, in contropartita, di non interferire negli affari dei mercanti genovesi.
I lavori iniziarono nel 1576 e proseguirono fino al 1591, su progetto dell’architetto Giorgio Di Fazio, mentre le edicole marmoree al suo interno, opera dell’artista Battista Carrabio furono completate solo nel 1650, grazie a sovvenzioni private. Un decreto del maggio 1579, emesso dai rappresentanti della Nazione, stabiliva le modalità per il recupero dei fondi autorizzando il console a prelevare tributi ed interessi sui commerci.
In tutto questo fervore edile fu coinvolto proprio il buon Orazio Lomellini, che si ritrovò improvvisamente nominato console della nazione genovese: così nel 1615, lui e Sofonisba si trasferirono a Palermo. Orazio, carico di onori e di impegni, le comprò una casa nell’antico quartiere arabo del Seralcadio, presso l’attuale Chiesa di Santa Maria del Piliere, dove l’ormai anziana pittrice continuò a dipingere nonostante le difficoltà alla vista che la portavano pian piano all’abbandono della sua arte. Ma la sua fama l’aveva preceduta a Palermo e Sofonisba fu messa a capo della commissione che doveva scegliere le pale d’altare della chiesa di San Giorgio dei Genovesi. Compito che svolse con notevole impegno, tanto da portare a Palermo due opere di Palma il Giovane.
Nel 1624 la peste infuriava sulla città e ne fu vittima anche il Viceré Emanuele Filiberto di Savoia. Era a Palermo, proprio in quei giorni, per un ritratto del Viceré, l’allievo di Rubens il grande Antoon Van Dyck. Il pittore olandese si recò a far visita alla collega anziana pittrice, che qualche anno prima lo aveva preceduto alla “Corte di Spagna”.
Van Dyck, che redigeva un suo diario, la trova pronta di memoria e di mente, cortesissima e ancora piena di interessi e di vita. Così scrive nel suo taccuino:
“ancora contò parte della vita di essa, per la quale si conobbe essere pittora de natura et miracolosa et la pena magiore che hebbe era per un mancamento di vista de non poter più dipingere”.

Il pittore le fece quindi un ritratto e lei lo pregò di non ritrarla troppo dall’alto,
”a ciò che le ombre nelle rughe della vecchiaia non diventassero troppo grandi”.
Malgrado i suoi due matrimoni Safonisba non ebbe figli e tenne sempre vivi i contatti con i lontani nipoti di Cremona e con il figlio naturale di Orazio Lomellini.
Il 16 novembre 1625 Sofonisba morì e fu sepolta nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi. Purtroppo la sua tomba è scomparsa, ma il Orazio, a futura memoria, ha fatto posare nella chiesa dei genovesi una commossa lapide, nel centenario della sua nascita.

Questa lapide ci presenta Sofonisba in modo quasi perfetto:
”Alla moglie Sofonisba, del nobile casato degli Anguissola, posta tra le donne illustri del mondo per la bellezza, straordinarie doti di natura, e tanto insigne nel ritrarre le immagini umane che nessuno del suo tempo potè esserle pari, Orazio Lomellini, colpito da immenso dolore, pose questo estremo segno di onore, esiguo per tale donna, ma il massimo per i comuni mortali”.
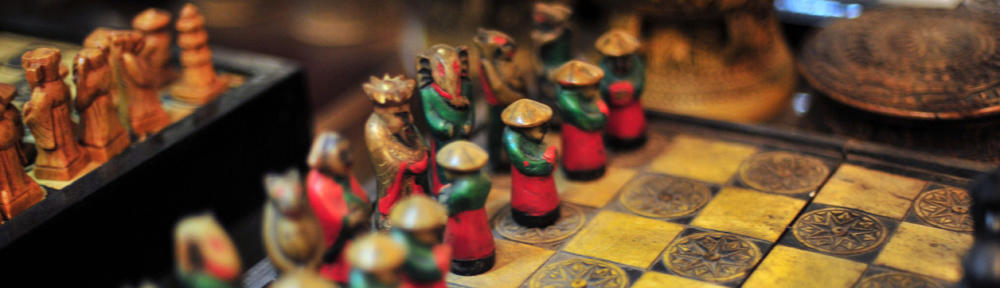
Pingback: San Domenico a Palermo (Parte II) | ilcantooscuro
Pingback: San Giorgio dei Genovesi | ilcantooscuro